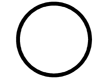Anamorfismi

Ambasciatori (1533) di Hans Holbein il Giovane

Affresco nel soffitto della Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio a Roma (1685) di Andrea Pozzo
Anamorfosi
Laboratorio delle Macchine Matematiche c/o Dipartimento di Educazione e Scienze Umane & Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche, Matematiche UNIMORENella proiezione di corpi tridimensionali sulla superficie piana del quadro (prospettiva artificiale) si devono determinare le dimensioni che essi devono avere sul piano del quadro affinché appaiano nelle giuste proporzioni quando si guarda con un solo occhio da un punto fisso. Accade così che proprio all'interno dei metodi elaborati per produrre immagini “scorciate” è contenuta la possibilità di anamorfosi. Rispettando pienamente le regole geometriche si possono ottenere figure distorte: se l'osservatore non colloca il proprio occhio esattamente nel punto previsto dall'artefice, risultano irriconoscibili o deformi (anamorfosi ottiche).
L’anamorfosi tra arte, percezione visiva e “prospettive bizzarre”
Paolo Di Lazzaro, Daniele Murra - EneaL’anamorfosi è un piccolo ma affascinante capitolo della prospettiva, ovvero la miscela di geometria e psicologia della percezione usata dagli artisti per rappresentare il mondo che ci circonda. In questo rapporto proponiamo l’emozione della lettura dell’anamorfosi e della prospettiva inversa, nel periodo storico in cui gli studi prospettici hanno influenzato i maggiori artisti del Rinascimento e del Barocco. Questa lettura arriva fino al giorno d’oggi, dove ritroviamo le tecniche anamorfiche nelle ardite opere d’arte prospettica su strada, e nella psicologia della percezione, per la quale “la sola realtà che cogliamo è quella percepita dal cervello”.
23 Stunning Anamorphic Artworks That Can Only Be Seen With A Mirror Cylinder
di Julija Nėjė - BoredPandaAnamorphic Art, Then and Now
di Ashley HurstavatarUsing a computer to visualise change in biological organisms
di John J O'Connor and Edmund F RobertsonDurer inventa(?) il morfing, e D’Arcy Thompson (1864-1948) applica alla natura.
Illusione ottica o anamorfosi: la nuova tendenza grafica
di Thibaud Genevois Franchi10 Amazing Anamorphic Street Artists

Pegasus, #streetart exhibition, EDF Foundation, Paris. “This piece was inspired by heraldic imagery,” says Mauro Italiano, a principal of Truly Design. “It’s a classic pose that you can find 1,300 years back in coats of arms.”
R-U-B-B-E-R Geometry (Topology)
di Jill Britton