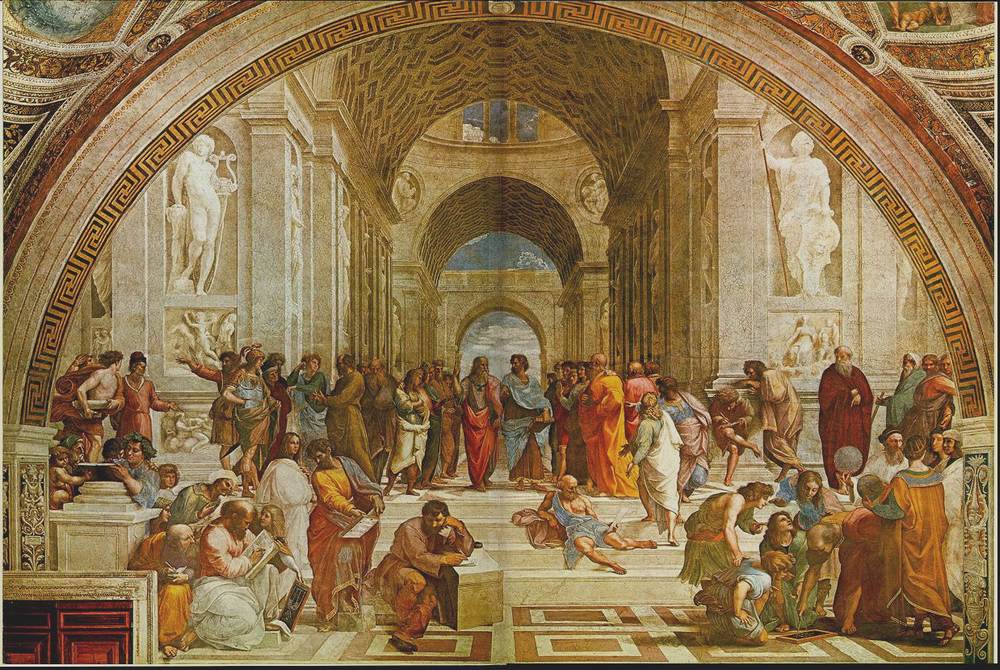La matematica è stata a lungo una forma di filosofia.
Per i pitagorici il numero era il principio. Il cosmo platonico era formato dai 5 solidi regolari; nel Timeo, associò a ognuno di essi un elemento: al tetraedro, spigoloso come una fiamma, il fuoco, al cubo la terra, all'ottaedro l'aria, all'icosaedro l'acqua, mentre nel Fedone ritenne che il dodecaedro fosse la forma dell'universo. Con Aristotele la matematica passa in secondo piano finché Galileo ne fa lo strumento principale per lo studio della realtà.
Con la specializzazione sempre più spinta dello studio delle questioni scientifiche e matematiche a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, che lascia agli scienziati e ai matematici meno tempo per occuparsi dei problemi ggnoseologici e etici, i filosofi si occupano con sempre più difficoltà di questi aspetti del pensiero.
Platone
(circa 429-347 aC)Matematica e filosofia in Platone
di Domenico MassaroUna riflessione seria sulla matematica e sulla filosofia della matematica nel mondo antico trova sempre ostacoli non lievi.
“Chi sa propriamente definire e dividere deve essere considerato un dio.”
“Non è degno del nome dell'uomo colui che non sa che la diagonale di un quadrato è incommensurabile con il suo lato.” “La matematica è come la dama: è adatta ai giovani, non troppo difficile, divertente, e senza pericoli per lo stato.”Aristotele
(384-322 a.C)“Dopo che le abilità pratiche si svilupparono a sufficienza per rispondere adeguatamente ai bisogni materiali, una delle scienze non dedicata a fini utilitaristici [la matematica] potè sorgere in Egitto, dato che la casta dei sacerdoti ebbe il tempo libero necessario per la ricerca disinteressata.”
“I cosiddetti pitagorici, che furono i primi a fare matematica, non solo la svilupparono ma vi si immersero completamente, credendo che i principi della matematica fossero i principi di tutte le cose.”
“Le scienze matematiche in particolare mostrano ordine, simmetria e limite: e queste sono le più grandi istanze del bello.”
dalla Metafisica
Ruggero Bacone
(1214-1292)in John Fauvel and Jeremy Gray (ed.), A History of Mathematics: A Reader, 1987
Leonardo da Vinci
(1452-1519)in N. Rose, Mathematical Maxims and Minims
Galileo Galilei
(1564-1642)Johannes Kepler
(1571-1630)Harmonices Mundi
su Progetto GutenbergHarmonices Mundi
traduzione del Liceo Scientifico Benedetto Croce - PalermoPremio Archimede 2018 - “Matematica è Cultura”
«La Terra è la sfera che misura tutte le altre. Circoscrivi ad essa un dodecaedro: la sfera che lo comprende sarà Marte [nel senso che contiene l'orbita, che allora ancora riteneva circolare, del suo moto attorno al sole]. Circoscrivi a Marte un tetraedro: la sfera che lo comprende sarà Giove. Circoscrivi a Giove un cubo: la sfera che lo comprende sarà Saturno. Ora inscrivi alla Terra un icosaedro: la sfera inscritta ad essa sarà Venere. Inscrivi a Venere un ottaedro: la sfera inscritta ad essa sarà Mercurio. Hai la ragione del numero dei pianeti»
Mysterium cosmographicum
“Lo scopo primario di tutte le investigazioni del mondo esterno dovrebbe essere scoprire l'ordine razionale e l'armonia che sono state imposte ad esso da Dio, e che Lui ci ha rivelato nel linguaggio della matematica.”
René Descartes
(1596-1650)“Ogni problema che ho risolto è diventato una regola che mi è servita in seguito a risolvere altri problemi.”
“Ho pensato che le seguenti quattro [regole] sarebbero state sufficienti, sempre che io avessi preso la decisione risoluta e invariabile di non mancare nemmeno una volta alla loro osservanza. La prima era di non accettare come vera una qualunque cosa per cui non avessi sufficiente evidenza del suo esserlo; cioè, evitare attentamente precipitazione e pregiudizi, e giudicare solamente quello che si presentava ala mia mente in maniera così chiara e distinta da non avere modo di dubitarne. La seconda, di dividere ogni problema che esaminavo in tante parti quante necessarie, e richieste per la sua soluzione. La terza, dirigere i miei pensieri in maniera ordinata; iniziando con gli oggetti più semplici, quelli più adatti ad essere conosciuti, e salendo man mano, con tutti i passi necessari, alla conoscenza dei più complessi; e stabilendo un ordine nel pensiero anche se gli oggetti non avessero alcuna priorità relativa tra di essi. L'ultima, di eseguire enumerazioni talmente complete e ricerche così generali che io potessi essere certo di non tralasciare nulla.”
“Queste lunghe catene di ragionamenti perfettamente semplici e facili, per mezzo dei quali i geometri sono abituati a portare avanti le loro dimostrazioni più complicate, mi hanno portato a immaginare che tutto quanto può far parte della conoscenza umana formi una simile successione; e che fintanto che evitiamo di accettare come vero ciò che non lo è, e preserviamo sempre la deduzione di una cosa da un'altra, non vi è nulla di così remoto che non possa essere alla fine raggiunto, o di così ben nascosto che non possa essere scoperto.”
Blaise Pascal
(1623-1662)“Chi è abituato a giudicare dalle sensazioni non comprende il processo del ragionamento, perché vuole comprendere con un'occhiata e non è abituato a cercare i princìpi primi. D'altro canto chi è abituato a ragionare dai princìpi primi non capisce per nulla le sensazioni, perché non è in grado di comprendere con un'occhiata.”
in W.H. Auden e L. Kronenberger (ed.), The Viking Book of Aphorisms,1966
“Il ragionamento è il metodo lento e tortuoso con il quale coloro che non conoscono la verità la possono scoprire. Il cuore ha il suo proprio ragionamento, che la ragione non conosce.”
“Pesiamo i guadagni e le perdite nello scommettere che Dio esiste. Consideriamo le due possibilità. Se vinciamo, vinciamo tutto; se perdiamo, non perdiamo nulla. Non esitate perciò a scommettere sulla Sua esistenza.”
“Ci sono due tipi di menti ... quella matematica, e quella che potremmo chiamare l'intuitiva. La prima arriva lentamente alle sue vedute, ma esse sono stabili e rigide; l'altra è dotata di maggior flessibilità e si applica simultaneamente alle diverse parti amabili di quello che ama.”
John Locke
(1632 – 1704 )“Ho affermato che le matematiche sono molto utili per abituare la mente a un raziocinioesatto e ordinato; con ciò non è che io creda necessario che tutti gli uomini diventino dei matematici, ma quando con questo studio hanno acquisito il buon metodo di ragionare, essi lo possono usare in tutte le altri parti delle nostre conoscenze.”
G. W. Leibniz
(1646 – 1716 )[…] il ragionamento vero e proprio dipende dalle verità necessarie od eterne, come son quelle della logica, dell'aritmetica, della geometria, che costituiscono la connessione indubitabile delle idee, e le conseguenze che non possono mancare. Gli animali che non colgono tali connessioni sono chiamati bestie; quelli, invece, che conoscono le verità necessarie, son propriamente coloro che vengono chiamati animali ragionevoli, e le loro anime son dette spiriti
da Principes de la nature et de la grâce, in Saggi filosofici e lettere;
Jean Le Rond D'Alembert
(1717-1783)Discours Preliminaire de L'Encyclopedie
Emmanuel Kant
(1724-1804)citato in The Mathematical Intelligencer, 13, n. 1, inverno 1991.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)“Riguardo alle verità matematiche, sarebbe considerato ancora meno geometra chi sapesse a memoriai teoremi di Euclide senza dimostrazioni, estrinsecamente, senza saperli intrinsecamente, [32] per dirla per antifrasi. Altrettanto insoddisfacente sarebbe ritenuta la conoscenza, ottenuta misurando molti triangoli rettangoli, che i loro lati stiano nel noto rapporto reciproco.
Tuttavia, anche nella conoscenza matematica la peculiarità essenziale della dimostrazione non ha ancora il valore e la natura di momento del risultato stesso, anzi in esso è piuttosto già passato e dileguato. In quanto risultato, il teorema è considerato vero, ma la circostanza così ottenuta non riguarda il suo oggetto ma è in rapporto solo al soggetto. Il movimento della dimostrazione, infatti, non appartiene all’oggetto, ma è una faccenda esterna. Così la natura del triangolo rettangolo non è decomposta, come rappresenta la costruzione necessaria a dimostrare il teorema, che ne esprime il rapporto. L’intera produzione del risultato è un processo e un mezzo del conoscere [soggettivo].
Anche nella conoscenza filosofica il divenire dell’esistenzain quanto esistenza è diverso dal divenire dell’essenzao della natura interna della cosa, ma in primo luogo la conoscenza filosofica le contiene entrambe mentre la matematica presenta solo il divenire dell’esistenza, cioè dell’esseredella natura della cosa nel conoscere come tale.”
da Phänomenologie des Geistes citato in Sulla matematica in Hegel e dalle nostre parti di Antonello Sciacchitano
Arthur Schopenhauer
(1788 – 1860)“Di tutte le facoltà intellettuali, il giudizio è l'ultimo a maturare. Un ragazzo di meno di quindici anni dovrebbe confinare la sua attenzione o ad argomenti come la matematica, nella quale gli errori di giudizio sono impossibili, o a soggetti in cui non sono molto pericolosi, come lingue, scienze naturali, storia, e così via.”
Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 – 1900)"(La matematica) certamente non sarebbe nata, se si fosse saputo fin da principio che in natura non esiste nè una linea esattamente retta, nè un vero cerchio, nè un'assoluta misura di grandezza”
"La scoperta delle leggi dei numeri é stata fatta in base all'errore già in origine dominante che ci siano più cose uguali (ma in realtà non c'é niente di uguale), o che perlomeno ci siano cose (ma non ci sono 'cose'). L'ammissione della molteplicità presuppone sempre già che ci sia qualcosa che si presenta come molteplice: ma proprio qui regna già l'errore, qui già fingiamo esseri e unità che non esistono. Le nostre sensazioni di spazio e di tempo sono false, giacchè, vagliate conseguentemente, conducono a contraddizioni logiche. In tutte le determinazioni scientifiche noi calcoliamo sempre inevitabilmente con alcune grandezze false: ma, poichè queste grandezze sono per lo meno costanti, come ad esempio la nostra sensazione dello spazio e del tempo, i risultati della scienza acquistano lo stesso perfetto rigore e sicurezza nella loro reciproca connessione; su di essi si può continuare a costruire- fino a quell'ultimo limite, dove le erronee premesse, quegli errori costanti, riescono in contraddizione con i risultati, come per esempio nella teoria atomica. Qui ci sentiamo ancor sempre costretti ad ammettere una 'cosa', o 'substrato' materiale che vien mosso, mentre l'intera procedura scientifica ha appunto perseguìto il compito di risolvere in movimento tutto ciò che si presenta come una cosa (che é materiale): anche qui noi distinguiamo ancora con la nostra sensazione ciò che muove e ciò che é mosso e non usciamo da questo circolo, perchè la fede nelle cose é fin dall'antichità connessa col nostro essere. Quando Kant dice che 'l'intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, ma le prescrive a questa', ciò é pienamente vero riguardo al concetto di natura che noi siamo costretti a collegare con essa (natura = mondo come rappresentazione, cioè come errore), che é però il compendio di una moltitudine di errori dell'intelletto. Le leggi dei numeri sono totalmente inapplicabili: esse valgono solo nel mondo umano".
"E' illusione che conosciamo qualcosa quando abbiamo una formula matematica per ciò che avviene: abbiamo solamente indicato, descritto: nulla di più ! "
in Umano, troppo umano.Bertrand Russell
(1872 – 1970)La matematica è una disciplina che, anche a partire dall'aspetto più semplice, può essere sviluppata in due direzioni opposte. La direzione più familiare è quella costruttiva che si sviluppa con una complessità gradualmente crescente; dai numeri interi alle frazioni, ai numeri reali, ai numeri complessi; dall'addizione e dalla moltiplicazione alla differenziazione ed alla integrazione, fino alla matematica superiore. L'altra direzione, che è meno comune, procede, per analisi, ad una nascente astrazione e semplicità logica; invece di ricercare quel che può essere definito e dedotto dalle asserzioni iniziali, cerca i concetti ed i princìpi più generali, nei cui termini quello che era il punto di partenza può essere definito o dedotto. È proprio il fatto di percorrere questa opposta direzione che distingue la filosofia matematica dalla matematica ordinaria.
da Introduzione alla filosofia matematica“La matematica non possiede soltanto la verità, ma anche la bellezza suprema, una bellezza fredda ed austera, come quella della scultura.”
“Quando ero giovane mi piaceva la matematica. Quando la matematica è diventata troppo difficile, mi sono dato alla filosofia, e quando la filosofia è diventata troppo difficile sono passato alla politica.”
Affare Sokal
Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity di Alan D. Sokal
Così come le femministe “liberal” si accontentano spesso di richieste minimali quali l’uguaglianza legale e sociale per le donne e la “libera scelta”, similmente i matematici “liberal” (e anche alcuni socialisti) si accontentano spesso di lavorare nel quadro egemonico di Zermelo-Fraenkel (che, riflettendo le sue origini “liberal” del diciannovesimo secolo, incorpora già l’assioma di uguaglianza), con l’unica aggiunta dell’assioma della scelta. Ma questo quadro risulta grossolanamente insufficiente per una matematica liberatoria, come dimostrato già da tempo da Cohen (1966).
La logica non dice nulla sul mondo, e attribuisce al mondo proprietà che non sono altro che costruzioni del pensiero teorico. Questo spiega perché la fisica a partire da Einstein si è basata su logiche alternative, come la logica trivalente che rifiuta il “principio del terzo escluso”.
da La vita grama delle scienze dure Franco Brezzi
Analitici e continentali: il mestiere del filosofo
di Alessandro Rosa“Tradizionalmente, la nascita della filosofia analitica viene fatta coincidere con la cosiddetta “svolta linguistica”, operata da Frege alla fine dell’Ottocento. Il presupposto di Frege era che i problemi filosofici fossero da considerare come problemi linguistici e, dunque, solo costruendo un linguaggio esente dalle imprecisioni della lingua naturale sarebbe stato possibile risolverli. Autori successivi (come Russell, Carnap, il primo Wittgenstein) presero alla lettera questa intuizione e gettarono le basi per questo nuovo modo di fare filosofia, ponendo tutta la loro attenzione sulla questione linguistica. Successivamente il metodo analitico si è esteso prevalentemente nei territori anglosassoni e scandinavi. Dall’altra parte, la filosofia continentale è quella che, come dice il nome, si sviluppa prevalentemente nel continente europeo (Francia, Germania, ma anche Italia) all’inizio del Novecento, con autori di spicco come Nietzsche, Adorno, Foucault e, a oggi, Žižek. Già questo breve elenco dovrebbe far capire che non esiste un vero metodo continentale di fare filosofia, dato che si tratta di autori molto diversi tra di loro. Piuttosto, i filosofi continentali tendono a occuparsi di problematiche più vicine alla sensibilità umana.”